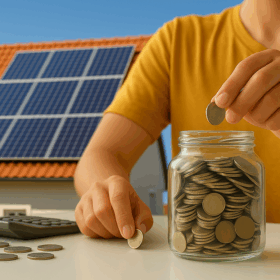Qual è La Sezione E Tensione Minima Di Un Cavo Fotovoltaico?
-
Le Caratteristiche Fondamentali Di Un Cavo Fotovoltaico: Sezione, Tensione E Durabilità
Quando si parla di impianti fotovoltaici, è naturale concentrarsi sui pannelli, sull’inverter o sull’accumulo. Tuttavia, spesso si dimentica un elemento fondamentale che può compromettere l’efficienza e la sicurezza di tutto il sistema: i cavi fotovoltaici. Questi conduttori, spesso nascosti alla vista, sono i veri e propri “vasi sanguigni” di un impianto solare, responsabili del trasporto dell’energia elettrica dal generatore (moduli) all’inverter e da lì verso le utenze o la rete.
Secondo quanto stabilito dalla norma CEI EN 50618 – che ha sostituito la precedente CEI 20-91 – i cavi per impianti fotovoltaici devono rispondere a specifici requisiti tecnici. Tra i più importanti vi sono la tensione nominale, che deve essere di 1.000 V in corrente alternata (AC) e di 1.500 V in corrente continua (DC), e la resistenza termica, che deve coprire un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e +120 °C, per garantire affidabilità sia in ambienti molto freddi che in presenza di forte insolazione.
I cavi devono inoltre essere identificati da sigle che ne descrivano la durata e le prestazioni termiche. Ad esempio, la marcatura PV20 indica una vita utile stimata di 20.000 ore a 120 °C, corrispondente a circa 25 anni di funzionamento in condizioni ordinarie. In questo modo, è possibile garantire che i cavi abbiano una vita utile in linea con quella dei pannelli fotovoltaici.
Ma al di là delle specifiche di isolamento e resistenza, la vera questione tecnica da affrontare è quella relativa alla sezione minima del cavo. Questa viene determinata in base alla lunghezza del cavo, alla corrente che vi scorre e alla tensione dell’impianto. Secondo quanto riportato dalla norma UNEL 35023, per cavi lunghi fino a 50 metri, la sezione minima non deve essere inferiore a 0,25 mm² per ampere. Questo significa che un cavo su cui scorre una corrente di 20 A, per esempio, dovrà avere una sezione di almeno 5 mm².
Naturalmente, la scelta della sezione non può essere fatta a occhio, né semplicemente adottando valori standard. Un cavo troppo sottile, infatti, produce perdite per effetto Joule (il calore generato dalla resistenza del cavo al passaggio di corrente) e può causare cadute di tensione significative, mentre un cavo sovradimensionato aumenta inutilmente i costi senza portare benefici proporzionati. È quindi essenziale trovare un giusto compromesso, ottenibile solo con un dimensionamento preciso.
Una regola sempre valida, comunque, è che un cavo più corto o di sezione maggiore comporta minori perdite di energia. Questa semplice osservazione ha conseguenze importanti in fase di progettazione dell’impianto, dove la disposizione fisica dei componenti può incidere direttamente sull’efficienza globale del sistema.
-
Calcolare La Sezione Corretta: Una Questione Di Resistenza E Caduta Di Tensione
La selezione della sezione del cavo fotovoltaico non è una questione puramente teorica: è invece un problema pratico risolvibile con la semplice applicazione della legge di Ohm, la quale rappresenta il legame tra corrente, resistenza e tensione in un circuito elettrico.
Immaginiamo di avere un impianto fotovoltaico dove il cavo positivo e quello negativo hanno una lunghezza di 1 metro ciascuno, per un totale di 2 metri di percorso elettrico. Se usiamo un cavo di 1,5 mm², la cui resistenza specifica è di circa 0,012 ohm/metro, otteniamo una resistenza complessiva di 0,024 ohm. Con una corrente massima di 20 A, la caduta di tensione sarà:
V = I x R = 20 A x 0,024 Ω = 0,48 V
In un impianto a 12 V, questa caduta rappresenta circa il 4% della tensione nominale, che è oltre il limite accettabile del 2% generalmente raccomandato per evitare inefficienze. In tal caso, è evidente che occorrerà utilizzare un cavo con una sezione maggiore, magari da 4 o 6 mm², per mantenere la caduta di tensione entro limiti accettabili.
Il principio generale è che la caduta di tensione è direttamente proporzionale alla corrente e alla lunghezza del cavo, e inversamente proporzionale alla sezione. Questo significa che raddoppiando la corrente o la lunghezza del cavo, anche la caduta di tensione raddoppia. Allo stesso modo, raddoppiando la tensione del sistema – ad esempio passando da 12 V a 24 V o a 48 V – la percentuale di caduta si riduce, migliorando l’efficienza.
Negli impianti connessi alla rete, che normalmente operano con stringhe da 500 a 1.000 V in continua, queste problematiche si riducono, ma non spariscono. Anche in tali contesti è essenziale contenere la caduta di tensione sotto il 2%, soprattutto tra i moduli e l’inverter, dove il percorso in DC è più sensibile alle perdite.
In definitiva, la scelta della sezione del cavo è un equilibrio tra costi e prestazioni, ma non va mai lasciata al caso. Un errore di dimensionamento può tradursi in perdite annuali di energia, sovraccarichi dei cavi, surriscaldamenti e persino incendi elettrici.
-
Il Sistema AWG: Un Altro Metodo Per La Selezione Dei Cavi
Nel mondo anglosassone, il dimensionamento dei cavi avviene con una logica diversa, basata sull’indice AWG (American Wire Gauge). Questo sistema, tuttora molto utilizzato nei manuali tecnici e nei prodotti di origine americana, è logaritmico e inversamente proporzionale alla sezione del cavo: in parole povere, più alto è il numero AWG, più sottile è il filo.
Ad esempio, un cavo AWG 1 ha una sezione di circa 42,4 mm², mentre un AWG 20 scende a 0,52 mm². Questa scala può generare confusione per chi è abituato ai millimetri quadrati, ma ha il vantaggio di essere estremamente dettagliata e di includere molte misure intermedie. Le tabelle di conversione AWG/mm² permettono di tradurre i dati e confrontare direttamente le prestazioni.
Un altro elemento interessante del sistema AWG è che esso include anche la resistenza specifica del cavo per unità di lunghezza. Questo consente di stimare in modo rapido la caduta di tensione senza calcoli complessi, semplicemente incrociando il valore AWG con la corrente e la lunghezza.
I cavi AWG sono spesso utilizzati negli impianti di accumulo, nei collegamenti tra batterie al litio e inverter, oppure nei sistemi off-grid dove si utilizzano accessori provenienti da mercati extra-europei. È dunque fondamentale conoscere questo standard, soprattutto quando si lavora con prodotti internazionali o si acquistano componenti online.
Nonostante l’adozione predominante del sistema metrico in Europa, l’AWG resta una risorsa utile per ingegneri e installatori, e un metodo efficace per valutare la compatibilità di componenti elettrici, soprattutto in impianti complessi o ibridi.
-
Tipologie Di Cavi Fotovoltaici: Materiali, Isolamenti E Applicazioni
Oltre alla sezione e alla resistenza, anche i materiali impiegati nella realizzazione dei cavi fotovoltaici rivestono un ruolo cruciale nella loro prestazione. In particolare, il conduttore può essere in rame o in alluminio. Il rame è più efficiente dal punto di vista elettrico – ha una resistività più bassa – ma anche più costoso e pesante. L’alluminio, invece, è più leggero ed economico, ma meno conduttivo e soggetto a maggior ossidazione, motivo per cui è sconsigliato o vietato per l’uso in ambienti interni.
Il rivestimento isolante, invece, è ciò che protegge il cavo dagli agenti atmosferici, dalle radiazioni UV, dagli attacchi chimici e dalle escursioni termiche. I materiali più comuni sono:
- PVC: economico, con temperatura massima di esercizio di 70°C, ma poco resistente alle basse temperature (fragile sotto i -15°C).
- Gomma EPR: temperatura massima di esercizio di 90°C, più flessibile, più adatto per impianti esterni e ambienti con forti escursioni termiche.
- XLPE (polietilene reticolato): usato in cavi ad alte prestazioni, resiste fino a 120°C e ha ottime proprietà meccaniche.
A questi si aggiungono guaine protettive in compound halogen-free, che in caso di incendio non emettono gas tossici, e sono oggi raccomandate per motivi di sicurezza ambientale e normativa.
Il colore del cavo, infine, segue uno standard convenzionale per facilitarne l’identificazione durante l’installazione e la manutenzione. Solitamente, il rosso viene impiegato per il polo positivo, il nero per il negativo e il giallo-verde per la messa a terra.
Tutti questi aspetti devono essere tenuti in considerazione durante la progettazione dell’impianto, in modo da garantire non solo prestazioni, ma anche affidabilità a lungo termine.
-
Connessione Alla Rete In Bassa Tensione: Requisiti E Norme Attuali
Una volta dimensionato e installato correttamente, l’impianto fotovoltaico deve essere collegato alla rete elettrica, ed è qui che entrano in gioco le normative relative alla connessione in Bassa Tensione (BT). In Italia, secondo le regole stabilite da ARERA e dal distributore locale, la tensione nominale è di 230 V per le forniture monofasi e 400 V per quelle trifase.
Gli impianti monofase possono arrivare fino a 6 kW di potenza nominale, con la possibilità di richiedere l’autorizzazione per estendere la potenza fino a 10 kW, se le condizioni di rete lo permettono. Negli impianti trifase, invece, si può installare potenza superiore, ma ciò comporta anche maggiori obblighi tecnici, tra cui l’utilizzo di inverter in grado di erogare energia reattiva e partecipare alla regolazione di tensione.
Con l’abolizione dello Scambio sul Posto a partire dal 2024, gli impianti fotovoltaici oggi operano prevalentemente in autoconsumo con vendita dell’eccedenza. Questo significa che ogni kWh non consumato direttamente viene ceduto alla rete e retribuito secondo i prezzi del mercato all’ingrosso (meccanismo del ritiro dedicato GSE).
Per registrare l’energia immessa e quella prelevata, è necessario installare due contatori: uno posto a valle dell’inverter, per misurare la produzione, e uno di scambio, a cura del distributore, per monitorare l’energia effettivamente immessa e consumata. Il corretto cablaggio, compresi i cavi in uscita dall’inverter, deve seguire precise normative CEI e disposizioni di Terna e del distributore locale.
È quindi chiaro come anche la fase di connessione, troppo spesso sottovalutata, richieda attenzione tecnica, conoscenza delle normative e una corretta selezione dei materiali, pena la non conformità dell’impianto e la perdita degli eventuali incentivi o corrispettivi previsti.